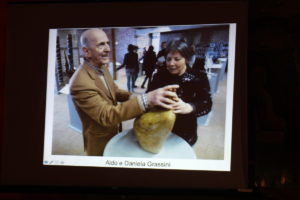Più che un seminario, l’intervento di Aldo Grassini, presidente e direttore del Museo Tattile Statale Omero di Ancona ad Arte per Tutti è stata una vera e propria Lectio Magistralis sull’inclusione culturale e sociale. Accompagnato da Annalisa Trasatti, responsabile dei servizi dello stesso museo, Grassini ci ha guidati, con leggerezza e ironia, in un lungo racconto sulla storia del Museo Omero, partendo dalle riflessioni generali e i principi fondanti che lo hanno ispirato.
Accessibilità Museale e dei Beni Culturali
La prima riflessione è sulle opportunità: oggi esistono strumenti che permettono di fare ciò che l’handicap impedisce di fare. In questo senso, l’istruzione è uno degli strumenti più potenti. La prima battaglia è quella culturale, un passaggio propedeutico fondamentale anche alla richiesta di protezione sociale. L’integrazione, infatti, è innanzitutto una forma di rivoluzione culturale.
Grassini spiega che una delle svolte epocali nella storia dell’inclusione in Italia si può far risalire alla Legge 517 del ’77 che ha decretato il diritto dei disabili a frequentare la scuola insieme agli altri studenti. Una svolta epocale che ha cambiato davvero l’intera impostazione pedagogica. E se una volta le mamme non volevano mandare i figli a scuola insieme ai bambini disabili, ora si cercano nuovi modi per misurarsi con la diversità. È l’onda lunga di questa famosa rivoluzione culturale del 1977: la scuola deve adattarsi alle esigenze di ciascuno e non il contrario.
Per questo motivo, anche i musei devono adattarsi alla realtà. Per molti anni la frequentazione da parte dei ciechi ai musei non era presa in considerazione, ma nel momento in cui queste persone si integrano davvero nella società, nasce la necessità di fruire dei beni culturali. La cultura è parte integrante della persona. Ad oggi, però, entrare in un museo per un cieco è molto spesso un’esperienza frustrante perché è tutto un “guardare ma non toccare”.
Da queste riflessioni nasce l’idea di aprire un luogo come il Museo Omero, nato dopo un lungo processo di incubazione e osservazione della realtà. Ora esiste da 24 anni e rappresenta un’esperienza davvero innovativa perché realizzata senza un vero modello di riferimento.
Inizialmente il Museo Omero era posizionato in tre stanze di una vecchia scuola di periferia. La situazione è cambiata nel tempo grazie soprattutto alla curiosità dei mezzi di comunicazione e all’avvicinamento dei primi turisti stranieri. Il passaggio dalla scuola periferica alla Mole Vanvitelliana ha permesso al Museo di crescere in modo esponenziale e di passare in soli due anni di attività da 11.000 visitatori annui a 25.000. Dal 2002 il Museo Omero funziona come un museo statale, con tutti i vantaggi e i problemi che questo comporta, da una maggiore della burocrazia all’aumento delle opportunità di crescita. Oggi il Museo Omero è una realtà che opera a livello internazionale.
La rivoluzione culturale che ha portato è pensare che le barriere non sono solo quelle architettoniche per le persone con disabilità motoria, ma anche sensoriali. Ogni disabilità ha le sue specifiche caratteristiche. Le persone sorde, ad esempio, hanno più problemi di comunicazione rispetto agli altri tipi di disabili.
Specificità diverse e, di conseguenze, bisogni differenti: le battaglie per l’accesso ai luoghi, ad esempio, sono state portate avanti dai disabili motori. Quest’ultimi in un museo, una volta superate le barriere di accesso, hanno libero accesso al patrimonio culturale esposto perché un museo è fatto per essere guardato. I sordi, invece, entrano e guardano, hanno più che altro un problema di comunicazione e di interpretazione. A fare la differenza sono i supporti di informazione e comunicazione.
Per gli psichici il discorso è completamente diverso: c’è un problema di accoglienza e di partecipazione con attività laboratori ad hoc e a fare la differenza è la formazione del personale.
I ciechi sono il problema più serio per la fruizione del museo perché possono andare dovunque ma non riescono a fruire del patrimonio esposto. Gli unici due sensi capaci di farci cogliere le forme sono la vista e il tatto. Se il museo è progettato sulla possibilità di vedere, come fa un cieco? L’unica soluzione è toccare.
Molto spesso i musei considerano questo aspetto secondario. Secondo la Dichiarazione dei Diritti umani del 1988, ogni essere umano ha il diritto alla cultura quale patrimonio dell’umanità e parte integrante dell’essere umano. Questo è un punto cruciale: il primo passo è convincersi che l’accessibilità è una necessità e, di conseguenza, trovare un modo per attivarla. La priorità, infatti, è ancora una volta culturale: è necessario capire che, anche con budget ridotti, un modo per affrontare la questione e dare delle risposte si può trovare. Bastano a volte piccoli accorgimenti, come la gestione dell’accoglienza. La persona disabile deve essere innanzitutto accolta nel modo più adatto, facendola sentire a casa e ascoltando le sue esigenze senza farla sentire “diversa”. Questo non è un costo impossibile perché la formazione è una pratica già avviata nelle strutture museali e andrebbe solo integrata con quella sull’inclusione e l’accessibilità.
Per quanto riguarda la fruizione, il punto non è diventare un museo “tattile”, ma far sì che in ogni museo ci sia la possibilità di conoscere le opere attraverso il tatto. Questo significa sfatare il falso mito secondo cui gli oggetti, se toccati, vengono deteriorati in modo irreparabile. Il divieto a toccare nei musei può essere accettato solo se motivato. Il bronzo, ad esempio, è un materiale che deve essere toccato perché è un materiale che vive meglio se toccato.
Il lungo discorso di Grassini ha toccato non solo le corde dell’accessibilità e l’inclusione, ma quelle più universali dell’esperienza estetica e della cultura quale valore fondante dell’essere umano. Le persone con disabilità, come tutti d’altronde, spesso visitano un museo insieme ai loro amici ed è insieme a loro che vogliono poter fruire del patrimonio museale. La socialità, infatti, è un valore fondante dell’esperienza culturale e questo può essere favorito grazie ad una specifica formazione del personale, mirata all’accoglienza delle persone con disabilità. D’altro canto, l’esperienza estetica non è solo conoscenza perché ci coinvolge anche sul piano emotivo ed è influenzata anche dalle persone che ci accompagnano. La socialità è quindi parte integrante della fruizione culturale e deve essere preservata.
Allo stesso tempo, il piacere della scoperta estetica è sempre un fatto soggettivo. La nostra civiltà ha scelto la vista ma la natura ci ha dato 5 sensi e se vogliamo conoscerla dobbiamo usarli tutti. Ogni senso ha la sua specificità e non sono intercambiabili. Da un punto di vista pratico, le informazioni che percepiamo tramite la vista non posso essere percepite allo stesso modo con il tatto ma si possono solo tradurre in indicazioni utili che ne supportano la comprensione. Questa è la funziona vicariante.
C’è un ostracismo nei confronti del tatto ma è culturale. In India, ad esempio, la forma di espressione più usata è la scultura e lì si può toccare tutto. Alcune caratteristiche sono peculiari di un senso o da un altro e questo vale anche per la piacevolezza delle singole sensazioni.
Partendo da una stimolazione sensoriale si attivano una serie di “corto circuiti” che non sono necessari, ma instaurano un rapporto soggettivo con quello che si conosce ed è una forma di libertà dell’esperienza estetica. Partendo da questo presupposto si innescano, come un detonatore che fa esplodere una bomba, associazioni e ricordi che sono personali, esistenziali e culturali.
In sintesi, è un bene anche per i normodotati sviluppare il tatto, perché arricchisce l’esperienza estetica di un elemento emozionale molto forte.
All’intervento di Grassini è seguito quello di Annalisa Trasatti che ha raccontato alla platea di Arte per Tutti la mission e le attività del Museo Omero. Una delle sue caratteristiche principali, infatti, è che viene frequentato da tanti vedenti. A tutti piace toccare, il tocco è ancora molto proibito ma è molto interessante e stimolante. La verità è che la diversità arricchisce tutti.
Un museo nato dall’esigenza di una fetta di popolazione, non è mai stato un museo per non vedenti, ma è un museo davvero per tutti. “È bello che ci copino questo tipo di apertura – spiega Trasatti – perché si lavora con i materiali, i libri tattili ecc., ed è interessante osservare come l’uso di supporti didattici nati per non vedenti, che fanno pensare alla disabilità, diventino dei pretesti per giocare, divertirsi e scoprire nuove cose. Il nostro è un lavoro culturale”.
Trasatti spiega ancora che l’allestimento del Museo Omero è sempre work in progress. La collezione comprende copie al vero, quindi calchi in gesso o resina di grandi capolavori e tanti pezzi di arte contemporanea. Molto spesso i visitatori arrivano ma non toccano, per un retaggio culturale che si portano dietro. Per questo motivo l’accoglienza è un fattore cruciale. Tutti al Museo Omero sono formati per gestire al meglio questa delicata fase. È fondamentale non rimanere spiazzati perché l’imbarazzo crea imbarazzo. Meglio fornire meno informazioni ma avere chiaro cosa si deve fare.
Nel caso dei non vedenti, è utile presentarsi e capire perché sono venuti e soprattutto carpire alcune informazioni quali se si tratta di un non vedente dalla nascita, se lo è diventato e da quando. Questo consente di adattare la spiegazione e a descrivere in modo diverso le opere: se il visitatore ha memoria visiva, nella spiegazione è possibile fare riferimento a colori o ad associazioni culturali che nel caso dei non vedenti dalla nascita sono inadatti. Bisogna essere formati e avere esperienza, una prerogativa che vale per tutti i musei. Comunicare la cultura è interessante ma anche molto difficile perché è necessario confrontarsi con culture, età e bisogni differenti. Lavorare con la disabilità è una buona palestra che permette di sviluppare una certa elasticità che solitamente non si ha con la formazione classica.
D’altro canto, accompagnare i non vedenti a una visita è sempre una fonte di scoperta per entrambi. Da subito si crea un contatto fisico perché è necessario prendere la persona per il braccio per guidarlo. Bisogna chiedere anche che tempi si hanno e cosa si conosce già, per adattare la visita alle necessità del fruitore. Conoscere attraverso il tatto, infatti, è un processo più lento, perché è un modo analitico rispetto alla vista che è un metodo sintetico. Attraverso il corpo, invece, è possibile fruire di massimo 10-12 pezzi, e questo ci aiuta a conoscere meglio le opere.
Tante le proposte didattiche presentate da Trasatti. Innanzitutto è utile ricordare che l’offerta di Omero è gratuita e prevede sempre “un’esperienza”. Fare solo un giro guardando è un’occasione persa quindi tutti i visitatori sono invogliati a conoscere le opere da bendati. È un modo interessante di fare esperienza estetica perché si entra in contatto con le proprie reazioni e l’accompagnatore diventa una figura fondamentale, innescando un piccolo gioco di ruolo a costo zero. Per questo motivo, quando si propone a una coppia di visitatori di diventare l’uno l’accompagnatore dell’altro, si offre un piccolo decalogo sul giusto modo per farlo.
Ogni target, inoltre, ha le sue reazioni. Per i ragazzi, ad esempio, entrare in contatto con le targhe in braille e fare un’esperienza di prova bendati è il modo migliore per avvicinarsi ai temi dell’accessibilità. Molto interessante è la reazione del pubblico straniero. L’italiano medio ha meno stupore estetico perché percepisce la presenza di copie come un limite. Gli stranieri invece una bella copia fatta a regola d’arte è una grande sorpresa e piace moltissimo.
Tra i laboratori proposti, inoltre, quello sul braille, sull’argilla e la LIS. Tra i progetti realizzati al di fuori del Museo, infine, la collaborazione con il Macerata Opera Festival e il Totem sensoriale, grazie al quale le scuole possono adottare un monumento e realizzare un piccolo libro informativo completo di descrizioni in braille e mappe in rilievo.
Trasatti ha chiuso con una citazione di Giuliano Vangi che sembra sintetizzare il senso di un’intera mattinata di riflessioni secondo cui “non puoi non toccare ciò che ami”.
Risvegliare i sensi è il monito finale di questa intensa lezione sull’inclusione e l’accessibilità.